Quando nasce un bambino, insieme a lui nasce anche una risorsa biologica unica: il cordone ombelicale e la placenta. Per decenni venivano considerati semplici “scarti” del parto; oggi sappiamo che, al contrario, custodiscono uno dei patrimoni più preziosi della medicina moderna: le cellule staminali.
Queste cellule non sono tutte uguali: nel sangue del cordone, nel tessuto che lo avvolge e nella placenta si trovano popolazioni diverse, ognuna con caratteristiche particolari. Insieme formano un arsenale biologico straordinario, capace di aiutare nella cura di malattie già oggi trattabili e di aprire prospettive per terapie future.


Nel sangue del cordone ombelicale si concentrano le cellule staminali ematopoietiche, quelle che danno origine a tutte le cellule del sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.
Sono le cellule più “famose” perché già oggi hanno cambiato la vita di migliaia di pazienti: vengono impiegate nei trapianti per più di 80 patologie, in particolare malattie del sangue come leucemie, linfomi, talassemie e gravi immunodeficienze.
Il vantaggio immunologico: rispetto al midollo osseo, il sangue cordonale è più “tollerante”. Questo significa che, anche se la compatibilità tra donatore e ricevente non è perfetta, il rischio di rigetto è più basso. È come se le cellule cordonali fossero più giovani e meno “rigide” nel riconoscere ciò che è estraneo, il che le rende preziose nei trapianti.
Il tessuto che avvolge i vasi del cordone, chiamato gelatina di Wharton, è ricco di cellule stromali mesenchimaliC (MSC). Queste cellule hanno un altro tipo di potere: possono trasformarsi in ossa, cartilagini, muscoli e tessuto adiposo.
Caratteristiche differenziative: le MSC non servono per ricostruire il sangue, ma per rigenerare tessuti solidi e modulare l’infiammazione. Sono cellule “architetto”, capaci di contribuire alla riparazione dei tessuti danneggiati.
Il plus immunologico: le MSC hanno una capacità naturale di calmare il sistema immunitario. Per questo vengono studiate per malattie autoimmuni (come la sclerosi multipla o il lupus), per rigenerare il cuore dopo un infarto o per riparare cartilagini e ossa.
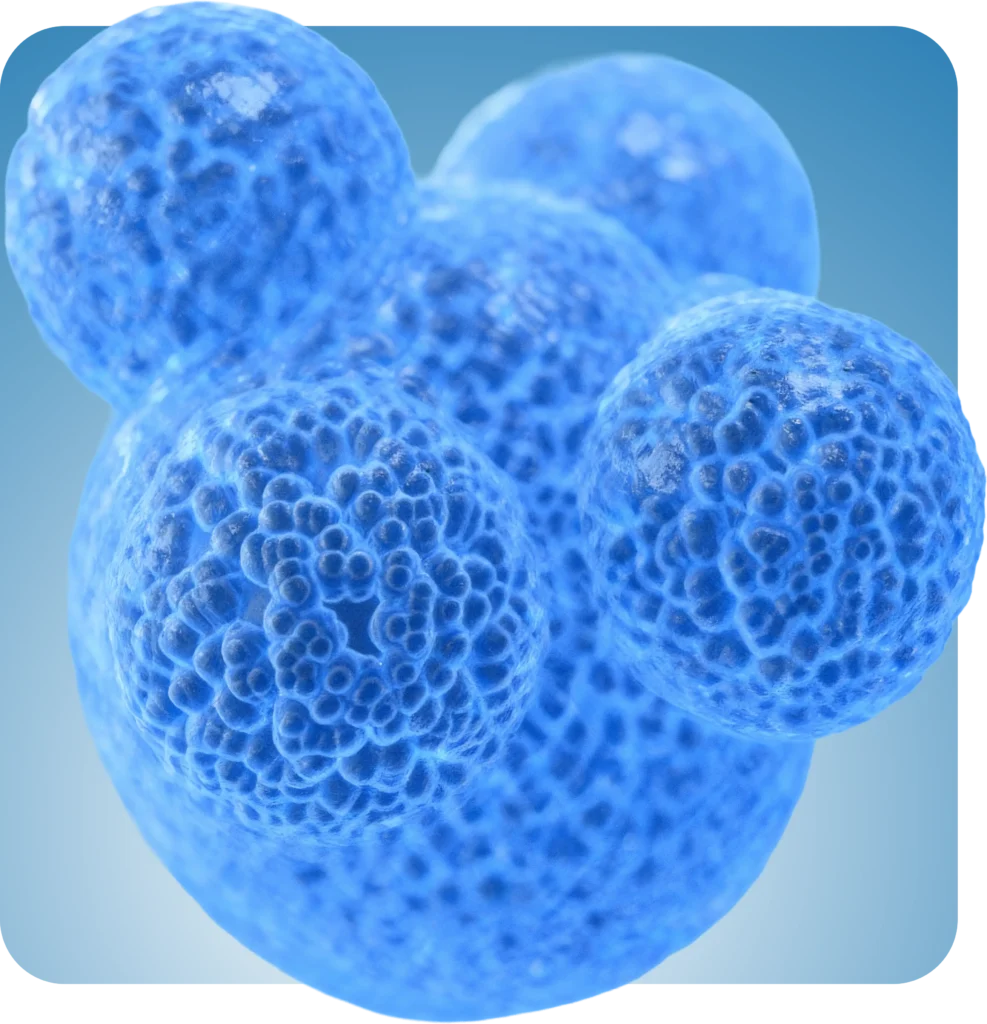

La placenta è spesso trascurata, eppure è un vero scrigno di cellule staminali. Contiene sia cellule ematopoietiche, simili a quelle del sangue cordonale, sia cellule mesenchimali, come quelle del tessuto cordonale. In altre parole, un doppio patrimonio biologico.
Oltre al potenziale clinico, la placenta ha un’altra caratteristica unica: è naturalmente programmata per gestire il dialogo immunitario tra madre e feto. Le cellule placentari ereditano questa capacità, diventando strumenti interessanti per future terapie che richiedono tolleranza immunologica e controllo delle infiammazioni.
Conservare queste cellule significa custodire un capitale biologico che appartiene al bambino e che, in alcuni casi, può essere utile anche per i fratelli o i genitori compatibili.
In sintesi: il cordone e la placenta non sono solo “memorie della nascita”, ma risorse terapeutiche e rigenerative che un giorno potrebbero fare la differenza tra avere o non avere una cura disponibile.
Grazie a processi certificati e sicuri offriamo servizi di qualità che rispettano i più alti standard del settore biotech.

L’azienda Biotech Svizzera certificataleader nella conservazione delle cellule staminali.
